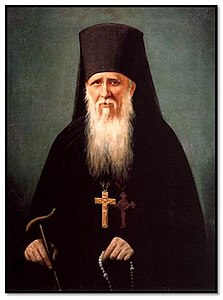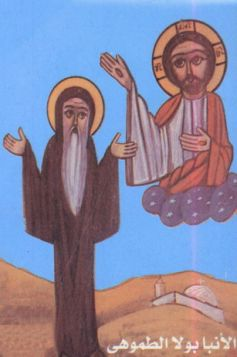Introduzione: Il problema del linguaggio nella trasmissione del Dharma
La pratica buddista, specialmente quando viene trapiantata dal contesto orientale a quello occidentale, si trova di fronte a una sfida fondamentale: come trasmettere insegnamenti che hanno origine in una matrice culturale, linguistica e filosofica profondamente diversa? Non si tratta semplicemente di tradurre parole da una lingua all'altra, ma di attraversare abissi concettuali che separano visioni del mondo radicalmente differenti.
Il linguaggio non è mai neutro. Ogni termine porta con sé strati di significato sedimentati nel tempo, connotazioni culturali, associazioni psicologiche e filosofiche. Quando parliamo di concetti fondamentali come "assenza di io" (anātman) o "assenza di ego", utilizziamo categorie che in Occidente hanno una storia propria, spesso incompatibile con l'intuizione originaria degli insegnamenti orientali. L'Occidente ha costruito la propria identità filosofica e psicologica attorno alla centralità dell'io: dal cogito cartesiano all'inconscio freudiano, dalla fenomenologia husserliana all'esistenzialismo sartriano. Parlare di "assenza di io" in questo contesto rischia di generare fraintendimenti: si potrebbe intendere una negazione patologica dell'identità, una dissociazione psicologica, o persino un nichilismo esistenziale.
Da qui nasce l'urgenza di un'analisi continua e di una precisazione del linguaggio. Non possiamo semplicemente accettare le traduzioni convenzionali; dobbiamo interrogarle, metterle in discussione, esplorarne le implicazioni. Prendiamo ad esempio il termine giapponese Shin (心), che può essere reso come "cuore", "spirito", "mente" o "essenza". Ciascuna di queste traduzioni orienta la comprensione in direzioni diverse. Se traduciamo il concetto di trasmissione Ishin Denshin (以心伝心) come "da cuore a cuore", evochiamo un'intimità emotiva, una relazione affettiva tra maestro e discepolo; se invece optiamo per "da spirito a spirito", ci spostiamo verso una dimensione più universale, meno personalistica, più vicina all'idea di natura di Buddha che trascende le individualità.
Questa ambiguità non è necessariamente un difetto da correggere, ma una caratteristica intrinseca del linguaggio quando si confronta con l'ineffabile. Le tradizioni orientali hanno sempre riconosciuto i limiti del linguaggio concettuale (prapañca nel buddhismo, vikalpa nel vedanta). Le parole possono indicare la luna, ma non sono la luna. Finché non raggiungiamo una comprensione diretta ed esperienziale, dobbiamo mantenere una certa sospensione del giudizio, considerando questi termini come approssimazioni provvisorie, tenendoli idealmente "tra virgolette" nella nostra mente.
Le due menti: la dualità provvisoria come strumento pedagogico
Nella tradizione Zen, in particolare nel lignaggio Rinzai che enfatizza la pratica dei kōan, si opera una distinzione metodologica tra due modalità della mente: la mente relativa (o ordinaria) e la mente assoluta. È fondamentale comprendere che questa distinzione è di natura pedagogica e provvisoria, non ontologica. Non esistono letteralmente due menti separate; piuttosto, si tratta di due modi di funzionamento della stessa consapevolezza.
La mente relativa è ciò che comunemente identifichiamo come il nostro "io". È il complesso psicofisico che pensa, decide, prova emozioni, percepisce sensazioni, forma giudizi, crea narrazioni. Questa mente opera secondo schemi, abitudini, condizionamenti. È la mente che dice "io voglio", "io penso", "io sono". È costruita attraverso la memoria, l'esperienza, l'educazione, la cultura. Funziona attraverso la discriminazione: separa il sé dal non-sé, il piacevole dallo spiacevole, il giusto dallo sbagliato.
Questa mente relativa non è intrinsecamente problematica. È necessaria per navigare il mondo fenomenico, per svolgere le attività quotidiane, per interagire con gli altri. Il problema sorge quando ci identifichiamo esclusivamente con essa, quando dimentichiamo che essa è solo una modalità parziale della consapevolezza, quando la scambiamo per la totalità di ciò che siamo.
La mente relativa opera attraverso la ripetizione. Le emozioni frequentemente sperimentate si cristallizzano in sentimenti stabili; i sentimenti danno origine a schemi di pensiero; i pensieri generano azioni; le azioni rinforzano le emozioni. Si crea così un circolo vizioso, un loop autoreferenziale che si perpetua automaticamente. Questo meccanismo è ciò che nel buddhismo viene chiamato saṃsāra, il ciclo della sofferenza.
Il Buddha individuò la radice della sofferenza (duḥkha) in questa visione individualista, egoica, separativa. Quando ci identifichiamo rigidamente con il nostro "io", inevitabilmente entriamo in conflitto con il mondo. Cerchiamo di piegare la realtà ai nostri desideri, di controllare ciò che è incontrollabile, di permanentizzare ciò che è impermanente. E poiché tutti gli altri esseri fanno lo stesso, ciascuno dal proprio punto di vista limitato, nascono conflitti, frustrazioni, sofferenze.
La mente assoluta, al contrario, è la consapevolezza non-duale, non-discriminante. È la natura di Buddha (buddha-dhātu, busshō 仏性), la capacità innata di illuminazione che tutti gli esseri possiedono. Non è qualcosa che deve essere acquisito o creato; è sempre presente, ma oscurato dalle nuvole della mente condizionata. È come il sole che è sempre lì, anche quando è coperto dalle nuvole.
Nella mente assoluta non c'è separazione tra soggetto e oggetto, tra sé e altro, tra interno ed esterno. C'è solo l'esperienza diretta, non mediata dal pensiero discorsivo. È la dimensione del suññatā (vacuità), non nel senso di nullità, ma nel senso di assenza di natura intrinseca separata. È la dimensione dell'interdipendenza (pratītyasamutpāda), dove ogni fenomeno esiste solo in relazione a tutti gli altri fenomeni.
Le due pratiche meditative: shikantaza e kōan
Nel lignaggio Zen esistono due approcci meditativi principali, apparentemente diversi ma complementari: la meditazione silenziosa (shikantaza, "solo sedere") e la pratica dei kōan.
La meditazione silenziosa, particolarmente enfatizzata nella scuola Sōtō fondata da Dōgen Zenji, è una pratica di pura presenza. Non c'è oggetto di meditazione, non c'è visualizzazione, non c'è mantra, non c'è nemmeno un'osservazione distaccata. È semplicemente essere, senza aggiungere nulla. Nella sua purezza ideale, non c'è nemmeno un osservatore che osserva: l'esperienza e la consapevolezza dell'esperienza sono una cosa sola. È la pratica della non-dualità diretta.
Dōgen descriveva questa pratica come shinjin datsuraku (身心脱落), "caduta di corpo e mente". Non si tratta di negare il corpo o la mente, ma di lasciar andare l'attaccamento all'idea di un sé sostanziale e separato. È praticare l'illuminazione stessa, non come uno scopo futuro da raggiungere, ma come realtà presente da manifestare.
La pratica dei kōan, invece, enfatizzata nella scuola Rinzai fondata da Eisai, utilizza un approccio apparentemente opposto. Anziché il silenzio vuoto, si lavora intensamente con un paradosso, una domanda, una storia enigmatica. Ma l'obiettivo ultimo è lo stesso: rompere l'identificazione con la mente ordinaria e aprire l'esperienza della mente assoluta.
È importante comprendere che queste due pratiche non sono in contraddizione. Sono come due porte diverse che conducono alla stessa stanza. La meditazione silenziosa opera attraverso il lasciare andare, il non-afferrare; la pratica dei kōan opera attraverso un'intensificazione che porta a un punto di rottura. Entrambe mirano a trascendere il funzionamento abituale della mente discriminante.
La natura e la struttura del kōan
Il termine kōan (公案) letteralmente significa "caso pubblico" o "documento ufficiale". Originariamente, nel contesto giuridico cinese, indicava un precedente legale utilizzato per stabilire la giurisprudenza. Nel contesto Zen, un kōan è un "caso" spirituale, spesso un dialogo o un'interazione tra un maestro e un discepolo, o un'affermazione paradossale, che viene utilizzato come strumento per catalizzare il risveglio.
I kōan hanno diverse forme. Alcuni sono domande apparentemente semplici ma impossibili da rispondere razionalmente, come il celebre "Qual è il suono di una sola mano?" (Sekishu no onjō 隻手の音声) di Hakuin. Altri sono storie di incontri tra maestri e discepoli, come i numerosi dialoghi raccolti nella Mumonkan (無門関, "La porta senza porta") o nel Hekiganroku (碧巌録, "La raccolta della scogliera azzurra"). Altri ancora sono affermazioni paradossali o gesti enigmatici.
Ciò che accomuna tutti i kōan è la loro resistenza alla comprensione concettuale. Non possono essere "risolti" attraverso il pensiero logico o l'analisi intellettuale. Sono progettati per creare un impasse nella mente ordinaria, per portarla a un punto morto dove deve arrendersi.
Il kōan funziona su tre livelli interconnessi:
1. Conoscenza della mente ordinaria
Il primo livello di lavoro con un kōan consiste nel prendere consapevolezza del funzionamento della propria mente ordinaria. Quando ci viene assegnato un kōan e cominciamo a lavorarci, inevitabilmente la nostra mente cerca di "risolverlo" usando gli strumenti abituali: l'analisi logica, l'associazione di idee, la ricerca di analogie, il ricorso alla memoria, la costruzione di ipotesi.
Ma il kōan è specificamente costruito per resistere a tutti questi approcci. Più cerchiamo di afferrarlo con la mente concettuale, più ci sfugge. È come cercare di afferrare l'acqua con le mani aperte: più stringiamo, più scivola via.
Questo processo di frustrazione è cruciale. Attraverso di esso, cominciamo a vedere direttamente come funziona la nostra mente: come reitera continuamente gli stessi schemi, come si attacca alle proprie interpretazioni, come cerca di ridurre il mistero a qualcosa di conosciuto e familiare, come cerca di mantenere il controllo.
Il kōan diventa uno specchio che riflette le nostre abitudini mentali. Vediamo la nostra tendenza a categorizzare, a giudicare, a concettualizzare. Vediamo come la mente non riesce a stare con l'incertezza, con il non-sapere, con l'ambiguità. Deve sempre avere una risposta, una spiegazione, una soluzione.
Questa consapevolezza è già di per sé trasformativa. Quando vediamo chiaramente la prigione in cui siamo rinchiusi, abbiamo già fatto il primo passo verso la libertà. Come disse il Buddha, la consapevolezza è l'inizio della liberazione.
2. Uscire dai limiti
Il secondo livello è quello della trascendenza. Dopo aver riconosciuto i limiti della mente ordinaria, dopo aver visto chiaramente le sbarre della prigione concettuale, diventa possibile andare oltre.
Questo "andare oltre" non è un processo graduale di miglioramento. Non è che comprendiamo sempre meglio fino a quando finalmente "capiamo". È piuttosto un salto, una discontinuità, una rottura. Nel linguaggio Zen, questo momento viene chiamato kenshō (見性, "vedere la propria natura") o satori (悟り, "risveglio").
È il momento in cui la mente ordinaria, portata al suo limite estremo, improvvisamente collassa o si apre. È come quando soffiamo in un palloncino: può espandersi fino a un certo punto, ma poi inevitabilmente scoppia. Non si trasforma gradualmente in qualcos'altro; c'è una rottura qualitativa.
In questo momento, c'è un'esperienza diretta della realtà non mediata dal pensiero concettuale. Non c'è più un soggetto separato che guarda un oggetto; c'è solo l'esperienza stessa, nella sua immediatezza e totalità. La distinzione tra sé e altro, tra interno ed esterno, tra osservatore e osservato, temporaneamente collassa.
Questa esperienza non può essere adeguatamente descritta a parole, proprio perché trascende il linguaggio concettuale. Coloro che l'hanno vissuta usano metafore e paradossi per indicarla: "vedere il proprio volto originale prima che i genitori nascessero", "il fondo del secchio che cede", "il risveglio da un sogno", "il ritorno a casa".
È importante sottolineare che questo non è uno stato mistico o soprannaturale. È, secondo lo Zen, la nostra condizione naturale e originaria, semplicemente non oscurata dalle costruzioni mentali. È vedere le cose come sono, tathātā (真如, shinnyo in giapponese), "tale-ità" o "cosità".
3. Vivere la realizzazione
Il terzo livello, e forse il più importante, è l'integrazione della realizzazione nella vita quotidiana. Nel linguaggio Zen, questo viene espresso con il detto: "Prima del risveglio, montagne sono montagne e fiumi sono fiumi. Al momento del risveglio, montagne non sono più montagne e fiumi non sono più fiumi. Dopo il risveglio, montagne sono di nuovo montagne e fiumi sono di nuovo fiumi."
Questo enigmatico detto esprime il percorso completo. Inizialmente, vediamo il mondo attraverso gli occhi della mente ordinaria, con tutte le sue divisioni e concettualizzazioni. Poi, nel momento del risveglio, queste categorie crollano e vediamo l'interdipendenza e la vacuità di tutti i fenomeni. Ma il percorso non finisce qui. Dopo il risveglio, ritorniamo al mondo fenomenico, ma ora con occhi diversi. Le montagne sono ancora montagne, ma non sono più separate da noi; i fiumi sono ancora fiumi, ma fluiscono attraverso di noi come noi fluiamo attraverso loro.
La realizzazione deve permeare ogni aspetto della vita. Non è qualcosa di speciale o separato, riservato a momenti di meditazione formale. È essere pienamente presente in ogni attività: camminare, mangiare, lavorare, parlare, dormire. È ciò che i Maestri Zen chiamano "praticare lo Zen nei mercati e nelle case da tè".
Questa integrazione non è automatica. Il kenshō iniziale, per quanto profondo, è solo l'inizio. È come aprire per un momento le imposte di una stanza buia e vedere la luce del sole. Ma poi le imposte si richiudono, e dobbiamo lavorare per tenerle aperte, per stabilizzare la realizzazione, per permetterle di trasformare gradualmente tutti gli aspetti della nostra vita.
Questo è il lavoro dei kōan successivi al primo risveglio. Nel sistema tradizionale Rinzai, ci sono collezioni di kōan organizzate in sequenze progressive. Dopo il kenshō iniziale, si continua a lavorare con kōan sempre più sottili, che esplorano diversi aspetti della realizzazione, che la approfondiscono, che la testano in situazioni diverse.
La domanda come risposta: il paradosso dell'indagine
Uno degli insegnamenti più profondi e controintuitivi della pratica dei kōan è che la domanda è già la risposta. Questo rovescia completamente il nostro approccio ordinario all'indagine.
Nella vita ordinaria, quando abbiamo una domanda, cerchiamo una risposta fuori di essa. La domanda è vista come un'espressione di ignoranza, e la risposta come qualcosa di separato che deve essere acquisito. C'è una distanza, una separazione tra domanda e risposta.
Ma lo Zen ci invita a guardare più a fondo. Perché poniamo una particolare domanda? Da dove nasce quella domanda? Chi è che sta chiedendo?
Prendiamo la classica domanda esistenziale: "Qual è il significato della vita?" La maggior parte delle persone cerca la risposta in filosofie, religioni, libri, insegnanti. Ma lo Zen ci chiede di tornare alla domanda stessa. Perché stai ponendo questa domanda? Cosa nella tua esperienza ti ha portato a formularla? Qual è il presupposto nascosto in essa?
Quando indaghiamo a fondo, scopriamo che la domanda stessa contiene già certi presupposti. La domanda "Qual è il significato della vita?" presuppone che la vita debba avere un significato, che questo significato sia qualcosa di separato dalla vita stessa, che possa essere catturato in una formula o definizione. Ma sono questi presupposti validi?
Inoltre, la domanda nasce sempre dalla mente ordinaria, con i suoi atti discriminanti. È ancora l'io che decide cosa è importante chiedere, cosa vale la pena investigare. È ancora la mente condizionata che opera attraverso categorie di significato e non-significato, importante e non-importante.
Quando vediamo chiaramente questo, quando vediamo che la domanda stessa è un prodotto delle nostre costruzioni mentali, qualcosa si scioglie. Non è che otteniamo una risposta alla domanda; è che la domanda stessa si dissolve. E nella sua dissoluzione, c'è una comprensione più profonda di quella che qualsiasi risposta concettuale potrebbe fornire.
Questo è ciò che il Maestro Zen Dōgen intendeva quando disse: "Studiare il buddhismo è studiare il sé. Studiare il sé è dimenticare il sé. Dimenticare il sé è essere illuminati da tutte le cose."
L'indagine, se condotta profondamente, non conduce a un accumulo di conoscenze, ma a una dissoluzione dell'indagatore stesso. E in quella dissoluzione c'è la vera comprensione.
Musutoku: la pratica senza spirito di guadagno
Un aspetto cruciale della pratica Zen, particolarmente rilevante nel lavoro con i kōan, è il concetto di musutoku (無所得), letteralmente "nessun ottenimento" o "non-acquisizione".
La mente ordinaria è sempre orientata al risultato. Facciamo le cose per ottenere qualcosa: lavoriamo per guadagnare denaro, mangiamo per saziarci, studiamo per acquisire conoscenze. Siamo costantemente proiettati verso il futuro, verso un obiettivo da raggiungere.
Questa mentalità si insinua anche nella pratica spirituale. Meditiamo per ottenere calma, pratichiamo per raggiungere l'illuminazione, lavoriamo sui kōan per avere il satori. Ma questa stessa orientazione al risultato è parte del problema, non della soluzione.
Quando pratichiamo con spirito di ottenimento, rafforziamo esattamente quella struttura egoica che stiamo cercando di trascendere. C'è ancora un "io" che vuole ottenere qualcosa, che misura i progressi, che si frustra se i risultati non arrivano, che si inorgoglisce se arrivano.
Musutoku significa praticare per la pratica stessa, non per ottenere qualcosa. Quando beviamo, beviamo semplicemente; non beviamo "per" dissetarci. La dissetazione può avvenire come conseguenza naturale, ma non è l'obiettivo che divide l'atto dal suo scopo.
Questo può sembrare un sottile gioco di parole, ma la differenza è profonda. Quando beviamo semplicemente, siamo completamente presenti nell'atto di bere: il sentire il bicchiere nella mano, il movimento del braccio, il contatto del liquido con le labbra, la sensazione di freschezza in bocca. C'è solo l'esperienza diretta, momento per momento.
Quando invece beviamo "per" dissetarci, siamo mentalmente proiettati verso il risultato futuro. Non siamo realmente presenti nell'atto; siamo già nella sensazione immaginata di non avere più sete. E così perdiamo l'unica cosa che è reale: questo momento presente.
Lo stesso vale per la pratica dei kōan. Se lavoriamo sul kōan "per" avere il satori, siamo già fuori strada. Il satori non è qualcosa che può essere ottenuto dall'io, perché il satori è esattamente la dissoluzione dell'illusione dell'io. È come cercare di addormentarsi sforzandosi: più ci proviamo, più restiamo svegli.
Musutoku non significa non avere direzione o intenzione. C'è certamente una direzione nella pratica Zen, un movimento verso la liberazione. Ma questa direzione non deve diventare un obiettivo da afferrare, un'acquisizione futura che nega la pienezza del presente.
Il Maestro Zen Suzuki Shunryū espresse questo paradosso magnificamente: "Non devi fare altro sforzo, basta che tu sieda. Ma devi sedere seriamente, come se la tua vita dipendesse da questo. Ma anche se siedi come se la tua vita dipendesse da questo, non devi aspettarti nulla."
Ishin denshin: la trasmissione da cuore a cuore
La pratica Zen è essenzialmente esperienziale, non intellettuale. Per questo motivo, la relazione diretta tra maestro e discepolo è assolutamente centrale. Questa relazione viene descritta con l'espressione Ishin Denshin (以心伝心), che può essere tradotta come "trasmissione da mente a mente", "da cuore a cuore" o "da spirito a spirito".
Come abbiamo visto, la scelta della traduzione non è neutra. Se diciamo "da cuore a cuore", enfatizziamo l'aspetto affettivo e relazionale; se diciamo "da spirito a spirito", ci spostiamo verso una dimensione più universale. Forse la traduzione più accurata è "da mente a mente", intendendo qui "mente" non nel senso della mente concettuale, ma della mente assoluta, della natura di Buddha.
Questa trasmissione non avviene attraverso le parole o i concetti. Le parole possono indicare, suggerire, provocare, ma non possono trasmettere direttamente la realizzazione. La realizzazione può essere solo riconosciuta da chi già la possiede, almeno in qualche misura.
Questo crea una situazione paradossale: come può qualcuno che non ha realizzato riconoscere la realizzazione in un altro? Come può un cieco scegliere una guida vedente tra una folla di ciechi che proclamano di vedere?
Qui entra in gioco la fiducia. Il discepolo deve sviluppare una fiducia profonda nel maestro, basata non su prove esteriori o su autorità istituzionali, ma su un riconoscimento intuitivo. Questa fiducia non è cieca credulità; è piuttosto una risonanza, un sentire che il maestro parla da un luogo di autenticità, da un'esperienza diretta.
Allo stesso tempo, il maestro deve guadagnarsi questa fiducia attraverso l'incarnazione vivente degli insegnamenti, attraverso la dimostrazione non di perfezione ma di genuinità. Un vero maestro Zen non pretende di essere perfetto o al di là dell'umano; manifesta semplicemente una libertà interiore, una capacità di rispondere alle situazioni con spontaneità e appropriatezza, senza essere intrappolato nelle reazioni egocentriche.
Il maestro ha un ruolo cruciale nell'assegnare i kōan. Non c'è un curriculum fisso uguale per tutti; il kōan deve essere scelto ad personam, in base alla situazione specifica del praticante in quel particolare momento del suo percorso. Un kōan che è perfetto per una persona in una certa fase può essere completamente inappropriato per un'altra persona o per la stessa persona in un momento diverso.
Questa personalizzazione richiede che il maestro conosca intimamente il discepolo, che comprenda profondamente dove si trova nel suo percorso, quali sono i suoi ostacoli specifici, quali sono le sue resistenze. Richiede anche che il maestro abbia una comprensione esperienziale dei kōan stessi, non solo intellettuale.
L'incontro formale tra maestro e discepolo, chiamato dokusan (独参) nel Rinzai Zen o sanzen (参禅) nel Soto Zen, è il momento in cui questa trasmissione si verifica più direttamente. In questi incontri privati, il discepolo presenta la sua comprensione del kōan al maestro.
Il maestro non sta cercando una risposta "corretta" nel senso convenzionale. Non c'è una formula da memorizzare. Il maestro sta verificando se c'è stata una vera penetrazione, un'esperienza diretta, o se si tratta solo di comprensione concettuale. I maestri Zen hanno sviluppato nei secoli metodi sofisticati per distinguere tra realizzazione autentica e imitazione intellettuale.
A volte la risposta può essere silenziosa, un gesto, uno sguardo. A volte può essere un'azione fisica, come girare le spalle e uscire dalla stanza. A volte può essere una risposta verbale paradossale. Ciò che conta non è la forma esterna, ma se proviene dalla mente ordinaria o dalla mente risvegliata.
Questa relazione maestro-discepolo può sembrare elitaria o autoritaria agli occhi occidentali moderni, abituati all'egualitarismo e all'autonomia individuale. Ma è importante comprendere che il maestro Zen non esercita un'autorità esterna; è piuttosto uno specchio che riflette al discepolo la sua propria natura di Buddha. Come disse il Maestro Linji: "Se incontri il Buddha, uccidi il Buddha. Se incontri un patriarca, uccidi il patriarca." Questo insegnamento sconvolgente significa che non dobbiamo attaccarci a nessuna figura di autorità esterna, nemmeno al Buddha stesso. L'obiettivo è realizzare la propria intrinseca libertà.
L'insegnamento nel paradosso: il kōan dell'albero
Consideriamo ora un kōan particolarmente ricco e stratificato, che illustra magnificamente come l'insegnamento Zen operi attraverso il paradosso:
"È come un uomo su un albero appeso a un ramo con una sola bocca. Le sue mani non arrivano al tronco, e con le mani non riesce ad afferrare nessun ramo. Neppure con i piedi riesce ad appoggiarsi ai rami sotto. Sotto l'albero arriva un altro uomo e gli chiede: Qual è il significato della venuta del patriarca da Ovest?" (cioè, qual è l'essenza dell'insegnamento buddista, o il significato della vita spirituale).
La situazione è paradossale: il maestro è in una posizione di estrema vulnerabilità, letteralmente appeso per i denti. Se apre la bocca per rispondere, cade e muore. Se non risponde, tradisce la compassione che dovrebbe essere al cuore dell'insegnamento buddista, lasciando il richiedente nell'ignoranza.
Ma questo è precisamente il punto. Il kōan ci pone di fronte a una situazione impossibile per la mente dualistica. La mente ordinaria cerca sempre di risolvere i problemi attraverso la scelta tra alternative: o rispondo o non rispondo, o vivo o muoio, o insegno o sto zitto. Ma la realtà non è sempre conforme a queste dicotomie.
Il maestro, rimanendo in quella condizione impossibile, sta già insegnando. Il suo essere lì, appeso, in quello stato di totale vulnerabilità e presenza, è l'insegnamento. Non c'è bisogno di parole. Anzi, qualsiasi parola aggiunta sarebbe una distrazione dall'insegnamento diretto che sta avvenendo.
Questo kōan ci insegna diverse cose simultaneamente:
Primo, ci mostra che la vera trasmissione non avviene attraverso le parole. L'insegnamento più profondo è non-verbale, è una dimostrazione diretta. Come disse Bodhidharma quando arrivò in Cina: "Una trasmissione speciale al di fuori delle scritture, non basata su parole e lettere, che punta direttamente alla mente umana, permettendo di vedere la propria natura e realizzare la buddhità."
Secondo, ci confronta con i nostri stessi attaccamenti. Quando leggiamo questo kōan, la nostra mente cerca immediatamente una "soluzione". Vogliamo salvare il maestro. Vogliamo che risponda alla domanda. Vogliamo che la situazione si risolva in un modo che ci faccia sentire confortevoli. Ma questa stessa necessità di risolvere, di sistemare, di rendere le cose comode e sicure, è parte del problema.
Terzo, ci mostra che la pratica autentica richiede la disponibilità a morire. Non necessariamente una morte fisica, ma la morte dell'io, la morte dei propri attaccamenti e certezze. Il maestro appeso all'albero ha già lasciato andare tutto. È in una posizione in cui non può fare affidamento su nulla se non sulla pura presenza. Questa è la posizione di chi ha veramente realizzato.
Il simbolismo dell'albero è ricco. L'albero è l'Albero della Vita, l'axis mundi che connette cielo e terra, l'albero della conoscenza, l'albero del Bodhi sotto cui Buddha si illuminò. Ha un tronco unico ma radici multiple che si estendono in profondità nel terreno, invisibili. Le radici rappresentano gli anni di pratica, le innumerevoli connessioni e interdipendenze che sostengono ogni manifestazione.
L'impossibilità del maestro di toccare l'albero se non con la bocca è significativa. La bocca è l'organo della parola, della definizione, del discorso. Ma qui la bocca non parla; semplicemente tiene, sostiene. Questo simboleggia l'impossibilità fondamentale di catturare la natura di Buddha in una definizione verbale. Qualsiasi cosa venga definita è già separata, limitata, ridotta. La natura di Buddha non è un oggetto che può essere afferrato concettualmente; è la stessa soggettività che cerca di afferrarla, è il processo stesso del cercare.