CLICCA SULLA BARRA QUI SOTTO PER SFOGLIARE IL MENU
Menu
- Chi sono
- Un evangelicalismo ecumenico nel Deserto
- Gli eremiti metropolitani
- Nuovo monachesimo
- La pietra d'inciampo (Temi scomodi)
- Amici
- Documenti
- La Fraternità dei Veglianti
- L'Ordine di San Luca
- Il congregazionalismo
- L'Universalismo cristiano
- Dialogo interreligioso
- Commento ai Salmi
- Dizionario della Musica Anglicana
- Storia della musica liturgica
- Libri
Il Rev. Dr. Luca Vona
Un evangelico nel Deserto
Ministro della Christian Universalist Association
Ministro della Christian Universalist Association
domenica 30 giugno 2024
La rete dalle maglie ben salde
venerdì 28 giugno 2024
Paolo Giustiniani e la vita eremitica come predicazione senza parole
Ireneo di Lione e la riconciliazione di ogni creatura in Cristo
Fermati 1 minuto. La comunione ritrovata
giovedì 27 giugno 2024
Fermati 1 minuto. Dare solidità alla parola
Lettura
Matteo 7,21-27
21 Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 22 Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demòni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? 23 Io però dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. 24 Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. 25 Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. 26 Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 27 Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande».
Commento
La parabola dell'uomo stolto e dell'uomo saggio, conclude il "Discorso della montagna", nel quale è racchiusa l'essenza del vangelo. Gesù spiega come riconoscere il vero credente. La fede che non porta frutto è incredulità.
Ma i frutti della fede non consistono nel compiere opere soprannaturali, miracoli e profezie, che presi di per sé non hanno alcun valore. Neanche la lode e la supplica - "Signore! Signore!" (v. 21) - contano qualcosa senza la conversione. Il vero frutto della fede consiste nel compiere la volontà di Dio, mossi dalla carità.
Come afferma l'apostolo Paolo "Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna" (1 Cor 13,1). Quando riconosciamo Cristo solo a parole non siamo tanto diversi da coloro che lo dileggiavano esclamando sotto la croce "Salve! Re dei giudei!" (Gv 19,3).
La grazia e la carità conducono gli uomini alla salvezza senza che compiano miracoli, mentre il compiere miracoli non ha mai salvato nessuno senza la grazia e la carità. Solo chi costruisce sulla salda roccia che è Cristo e non chi confida in se stesso può resistere alle prove della fede, che saranno tante in questa vita: "Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!" (Gv 16,33).
Non è abbastanza ascoltare le parole del Vangelo, comprenderle, ricordarle, ripeterle e disputare su di esse. Dobbiamo essere capaci di "dare solidità" alla parola, facendoci costruttori della chiesa di Cristo e affidando le sue fondamenta non alla sabbia della nostra umana povertà ma alla roccia della sua grazia.
Preghiera
Signore, donaci la beatitudine di essere tra coloro che ascoltano la tua parola e la osservano, per essere pietre vive nell'edificio della tua chiesa. Amen.
- Rev. Dr. Luca Vona
mercoledì 26 giugno 2024
Mari, disseminatore di comunità cristiane in oriente
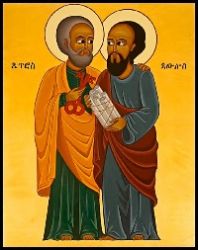 |
| Addai e Mari (I-II sec.) |
Fermati 1 minuto. I frutti buoni della fede
martedì 25 giugno 2024
Massimo di Torino. Nessuno diceva propria qualche cosa
 |
| Massimo di Torino (?-420) |
Fermati 1 minuto. Il decentramento necessario
lunedì 24 giugno 2024
Nascita di Giovanni il Battista, frutto della promessa
Fermati 1 minuto. La migliore versione di noi stessi
Lettura
Luca 1,57-66.80
57 Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. 58 I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia, e si rallegravano con lei. 59 All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. 60 Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». 61 Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». 62 Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. 63 Egli chiese una tavoletta, e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. 64 In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. 65 Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. 66 Coloro che le udivano, le serbavano in cuor loro: «Che sarà mai questo bambino?» si dicevano. Davvero la mano del Signore stava con lui. 80 Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele.
Commento
Il più grande conforto che possiamo avere dai nostri figli è di metterli nelle mani di Dio. Per questo la circoncisione, che è stata sostituita, nella nuova alleanza, dal battesimo cristiano, diviene occasione di gioia più grande della stessa nascita.
L'usanza giudaica era quella di dare nome al bambino proprio in occasione della circoncisione, così come Abramo ricevette un nome nuovo dopo aver sancito l'alleanza con Dio mediante questo segno esteriore. Il Signore, infatti, chiama per nome coloro che sono affidati a lui, il che significa che non è solo genericamente il Dio del popolo dei salvati, ma il Padre di ciascuno di noi, che così possiamo chiamarlo in virtù del rapporto personale e filiale che abbiamo con lui.
Questo rapporto, insito in un "nome nuovo", unico, che ci viene attribuito è ben rappresentato dal "contenzioso" tra Elisabbetta e gli amici e parenti giunti per assistere alla circoncisione di Giovanni. Questi suggeriscono di chiamarlo Zaccaria, come il padre, ma lei si oppone e mossa dallo Spirito Santo afferma risolutamente che si chiamerà Giovanni.
Comunicando con Zaccaria mediante segni, i vicini e parenti ottengono anche da lui la risposta scritta che il bambino dovrà chiamarsi Giovanni. Muto e sordo, Zaccaria non può fare a meno di esprimere la volontà di Dio. Quando lo Spirito parla sa come farsi sentire. Così affermerà Gesù, quando i farisei rimprovereranno la folla esultante al suo ingresso a Gerusalemme: "se questi taceranno, grideranno le pietre" (Lc 19,40).
Compiuta la volontà di Dio sul bambino la lingua di Zaccaria si scioglie in un canto di lode. Giovanni susciterà meraviglia e la sua fama si spargerà per le regioni circostanti fin dall'infanzia, anticipando quella che otterrà con l'inizio del suo ministero profetico, quando folle di peccatori verranno a lui in cerca di conversione. Ci si sarebbe aspettato di vedere Giovanni sacerdote come suo padre. Ma i piani di Dio per lui erano altri. Egli sarebbe diventato un profeta. Il più grande dei profeti.
Dio ci ama nella nostra specificità e ha un piano di salvezza e di santità particolari per ognuno di noi. Chiediamogli la grazia per imparare ad essere la migliore versione di noi stessi, piuttosto che la brutta copia di qualche santo.
Preghiera
O Dio, che ci chiami per nome, rivelaci la tua volontà ed effondi su di noi il tuo Spirito, affinché possiamo portarla a compimento a lode del tuo Nome. Amen.
- Rev. Dr. Luca Vona
domenica 23 giugno 2024
Tutto il mondo creato è in travaglio
sabato 22 giugno 2024
John Fisher e Thomas More, martiri riabilitati dalla Chiesa d'Inghilterra
 |
| John Fisher (1469-1535) |
Sempre a Londra, due settimane dopo John Fisher, il 6 luglio 1535 sale sul patibolo sir Thomas More.
giovedì 20 giugno 2024
Nicola Cabasilas e la vita in Cristo
Fermati 1 minuto. Gesù maestro di preghiera. Commento al Padre nostro
mercoledì 19 giugno 2024
Romualdo e il monachesimo integrale
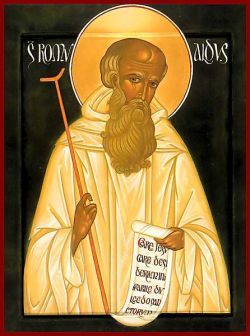 |
| San Romualdo (+ 1027) |
Fermati 1 minuto. Quale mèta rincorriamo?
martedì 18 giugno 2024
“Non è un luogo di culto”. La Corte di Cassazione ribalta le precedenti sentenze
Fermati 1 minuto. Supplemento di amore
lunedì 17 giugno 2024
Fermati 1 minuto. La perfezione della giustizia, frutto della grazia
Lettura
Matteo 5,38-42
38 Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; 39 ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra; 40 e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 41 E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. 42 Da' a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle.
Commento
Gesù cita la legge del taglione, applicata nel mondo antico, secondo la quale si infligge al responsabile di una lesione personale la stessa lesione da lui provocata alla vittima. Questa legge (Es 21,24; Dt 19,21; Lv 24,20) ha lo sopo di moderare la vendetta, nel senso di non assegnare una lesione superiore al male ricevuto. Per offese meno gravi, come le ingiurie, era permesso un risarcimento pecuniario.
Gesù proibisce ogni forma di riparazione compensativa, non per una passività fine a se stessa, bensì per un atteggiamento tendente a indurre il nemico a cambiare e a vivere secondo giustizia.
Non opporsi al malvagio significa qui non reagire a chi ci fa del male contraccambiandolo sul piano personale o perseguendolo sul piano giudiziario. Una simile predisposizione al perdono può nascere dalla consapevolezza di essere stati noi per primi perdonati e giustificati da Dio per le nostre mancanze.
Questo atteggiamento riguarda la sfera personale e non la lotta contro azioni criminali (Rm 13,4) o aggressioni militari.
Solo il primo dei cinque esempi portati da Gesù riguarda direttamente la riparazione di un torto subito; gli altri invece mettono in evidenza la liberalità del comportamento cristiano.
Non reagire alle offese attesta il rimettere a Dio il giudizio. Ma la perfezione della nuova legge è espressa dalla preghiera per i propri nemici (Mt 5,44), di cui Gesù stesso dà testimonianza sulla croce: "Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno" (Lc 23,34). Solo la grazia santificante può renderci capaci di giungere a un grado così alto di perfezione.
Dare il mantello (lunga veste esterna) era un sacrificio più grande che non dare la tunica (veste interna). Inteso anche nella sua dimensione spirituale questo atto significa coprire sotto il manto della misericordia le mancanze del prossimo.
Compiere due miglia con chi chiede di accompagnarlo per uno indica la disponibilità a prestare il proprio tempo e il proprio sostegno a chi ne ha bisogno. Deviare dalla propria strada per accompagnare il nostro prossimo sulla sua è spesso un sacrificio che ci costa grande fatica, perché il tempo è spesso quanto di più prezioso abbiamo a disposizione. Gesù risorto, sulla via di Emmaus, si farà compagno dei due discepoli lungo il loro cammino, confortandoli dalla tristezza e spiegandogli le Scritture.
Gesù invita poi alla generosità; chiedere di dare un prestito a chi ne ha bisogno equivale a imitare la stessa magnanimità di Dio, il quale ci ha dato la vita, i beni della creazione, i nostri talenti personali, e ci soccorre con la sua grazia. Un mondo in cui ciascuno applicasse la stessa giustizia di Dio, riguardo la quale Gesù afferma "chiedete e vi sarà dato" (Lc 11,9), sarebbe un mondo giusto e solidale. Un mondo che applicasse il suo comandamento di amarci gli uni gli altri come egli ha amato noi (Gv 15,12) camminerebbe sulle vie della pace (Lc 1,79).
Preghiera
Porta a perfezione la nostra giustizia, Signore, affinché facendoci tuoi imitatori possiamo contribuire all'avvento del tuo regno. Amen.
- Rev. Dr. Luca Vona



















